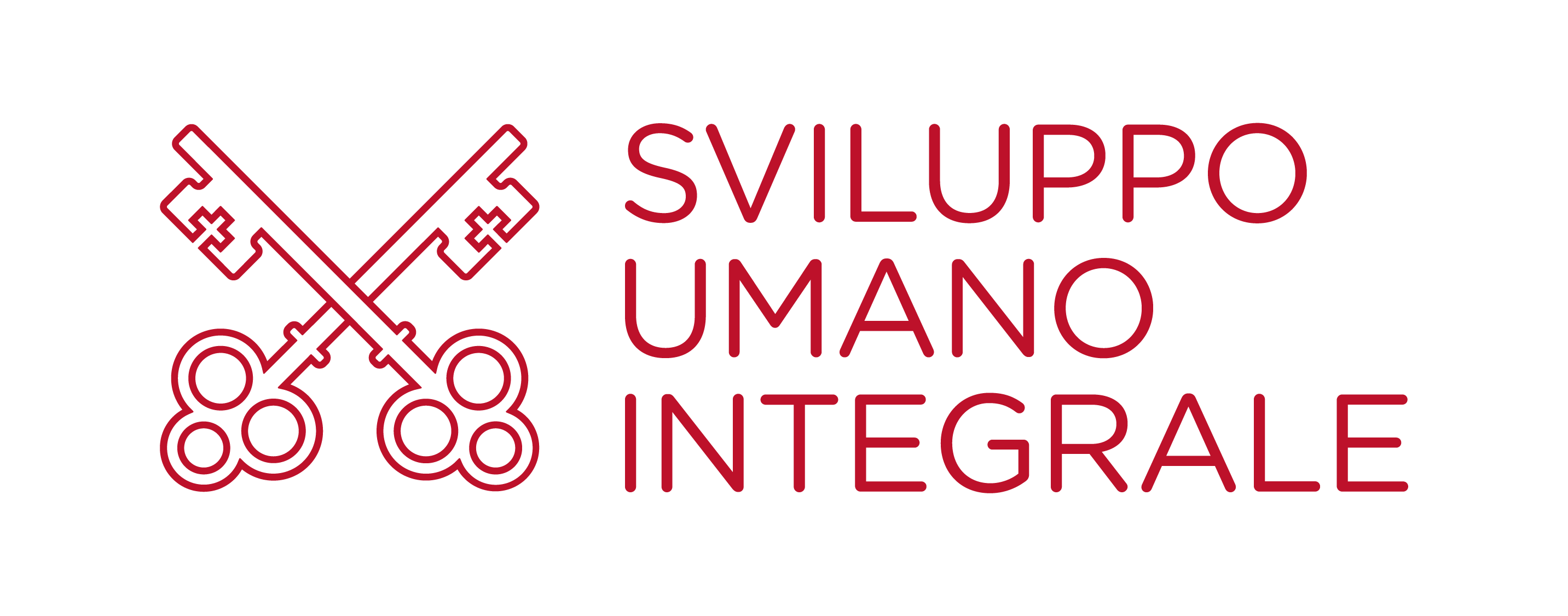Mi chiamo Giorgia, ho 19 anni, abito a Nonantola, un paese in provincia di Modena. Ero alla fine della terza superiore quando ho iniziato a fare servizio, attraverso gli scout, alla scuola di italiano per stranieri “Frisoun”. Mi sono subito affezionata a questo ambiente sempre accogliente e “colorato”, non solo per le diverse sfumature della pelle, ma anche per la moltitudine dei sorrisi e delle storie di vita che ogni lezione regala. Ho iniziato quando gli studenti a scuola erano solo gli stranieri residenti a Nonantola da tempo che non si erano ancora integrati del tutto o da poco arrivati legalmente in Italia per ricongiungersi con i parenti, per cercare un lavoro.
Mi chiamo Giorgia, ho 19 anni, abito a Nonantola, un paese in provincia di Modena. Ero alla fine della terza superiore quando ho iniziato a fare servizio, attraverso gli scout, alla scuola di italiano per stranieri “Frisoun”. Mi sono subito affezionata a questo ambiente sempre accogliente e “colorato”, non solo per le diverse sfumature della pelle, ma anche per la moltitudine dei sorrisi e delle storie di vita che ogni lezione regala. Ho iniziato quando gli studenti a scuola erano solo gli stranieri residenti a Nonantola da tempo che non si erano ancora integrati del tutto o da poco arrivati legalmente in Italia per ricongiungersi con i parenti, per cercare un lavoro.
Il 26 aprile 2017 era prevista una delle riunioni di programmazione delle lezioni successive, ma la sera stessa mi arrivò un SMS: quella sera avremmo conosciuto “i nuovi profughi”, una decina, che sarebbero stati ospitati a Nonantola. All’epoca conoscevo le storie dei migranti solo per le notizie sugli sbarchi a Lampedusa, perché i telegiornali non facevano altro che parlare di quello da diverso tempo, ma incontrarli di persona quella sera ha avuto un effetto ben diverso. Erano in cerchio, in silenzio, in attesa – l’ennesima del loro lungo viaggio – prima di essere trasferiti in un nuovo edificio, non si conoscevano tutti tra di loro e soprattutto avevano gli sguardi che parlavano da soli: c’era chi scambiava qualche mormorio col vicino, chi aveva la faccia assonnata, chi si guardava intorno incuriosito. Questo è stato il primo incontro con loro e due cose mi hanno subito colpito: la loro completa fiducia in chi li stava accogliendo (erano in balìa di decisioni prese da altri) e il fatto che fossero tutti giovani – avevano giusto qualche anno in più di me se non addirittura la stessa età – e io sarei diventata una loro maestra.
Ora a Nonantola sono accolti circa una sessantina di richiedenti asilo e un buon numero di questi frequenta la scuola di italiano insieme agli altri studenti di vecchia data. Inizialmente facevo fatica a parlare con loro, a confrontarmi con il loro passato doloroso. Mi facevano vedere le foto della loro famiglia lontana, mi raccontavano del fratello o della sorella che avrebbero voluto rivedere, della casa che era andata distrutta durante un’alluvione, della Libia, del lungo viaggio, e tuttora a volte sento di non avere le parole giuste per confortarli, impotente di fronte alla loro sofferenza.
 Una volta andai a cena a casa di un gruppo di ragazzi (Mohammed, Ablaye, Mansoor, Adama) e rimasi scandalizzata quando, dopo aver posto al centro del tavolo un unico grande piatto di cous cous, iniziarono a mangiare da quello con le mani, senza le posate. Abituata ad un mondo in cui si mantengono sempre le distanze, subito rimasi perplessa, ma questa tradizione africana ti dimostra che per essere accoglienti non basta fornire i mezzi per vivere, offrire una casa e del cibo, che ovviamente sono fondamentali, ma è necessario mettersi intorno allo stesso tavolo, in un rapporto di parità, sentirsi fratelli e condividere ciò che si ha con molta semplicità.
Una volta andai a cena a casa di un gruppo di ragazzi (Mohammed, Ablaye, Mansoor, Adama) e rimasi scandalizzata quando, dopo aver posto al centro del tavolo un unico grande piatto di cous cous, iniziarono a mangiare da quello con le mani, senza le posate. Abituata ad un mondo in cui si mantengono sempre le distanze, subito rimasi perplessa, ma questa tradizione africana ti dimostra che per essere accoglienti non basta fornire i mezzi per vivere, offrire una casa e del cibo, che ovviamente sono fondamentali, ma è necessario mettersi intorno allo stesso tavolo, in un rapporto di parità, sentirsi fratelli e condividere ciò che si ha con molta semplicità.
A scuola io provo ad insegnare le lettere e la grammatica italiana, i ragazzi migranti mi insegnano invece l’importanza delle relazioni, la bellezza di un “grazie” sentito col cuore, la ricchezza di tante prospettive, la pazienza, ad avere speranza nel futuro, perché, come mi ha detto Bacari l’altro giorno: “un bambino quando nasce non corre subito”.
Ora quando cammino per Nonantola e mi capita di incontrare uno di loro sono tranquilla, mi fa piacere scambiare due chiacchiere con lui, gli ricordo di essere puntuale a scuola e se sono insieme ad altri amici lo presento anche a loro: se tutti noi aprissimo il nostro cuore scopriremmo che i migranti non sono qualcosa di cui avere paura, ma sono un dono di Dio nella nostra vita.
Questa è stata la mia esperienza ed auguro a tutti di accogliere l’invito di papa Francesco, che è l’invito di Gesù, e di scoprire così che nei migranti Dio ci dona dei fratelli che arricchiscono la nostra vita.
Giorgia