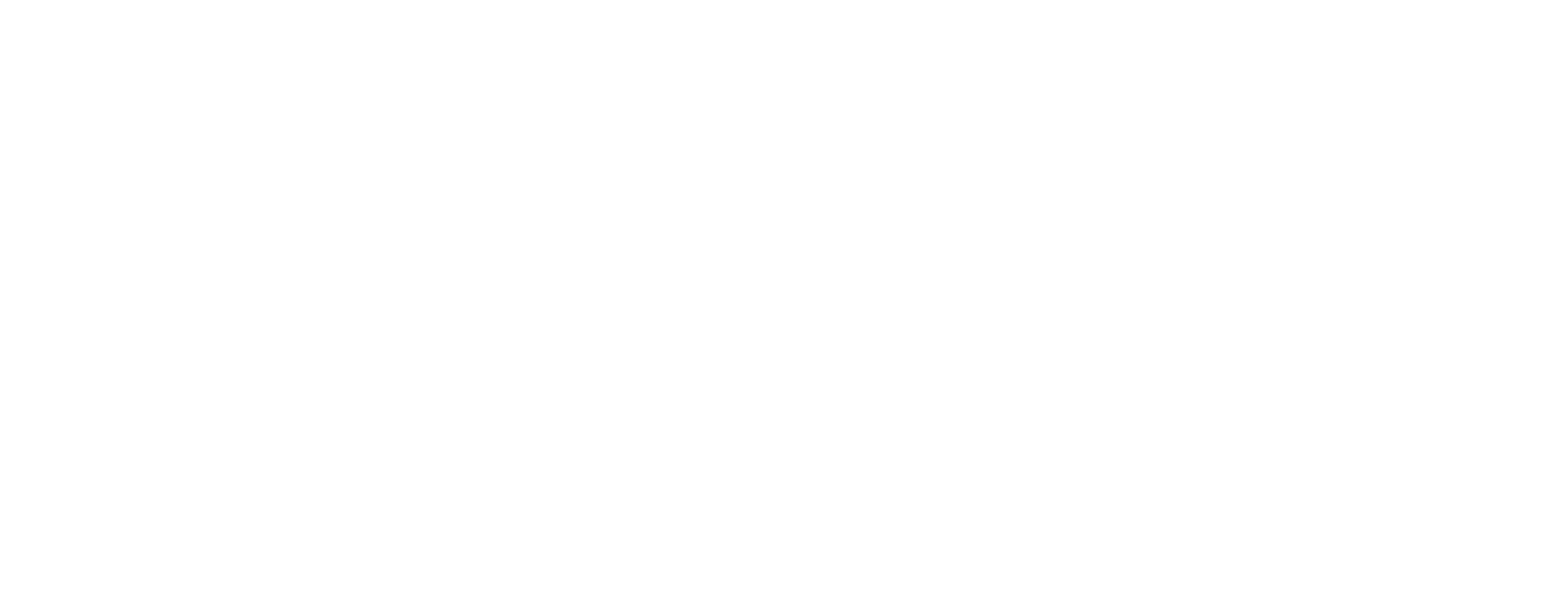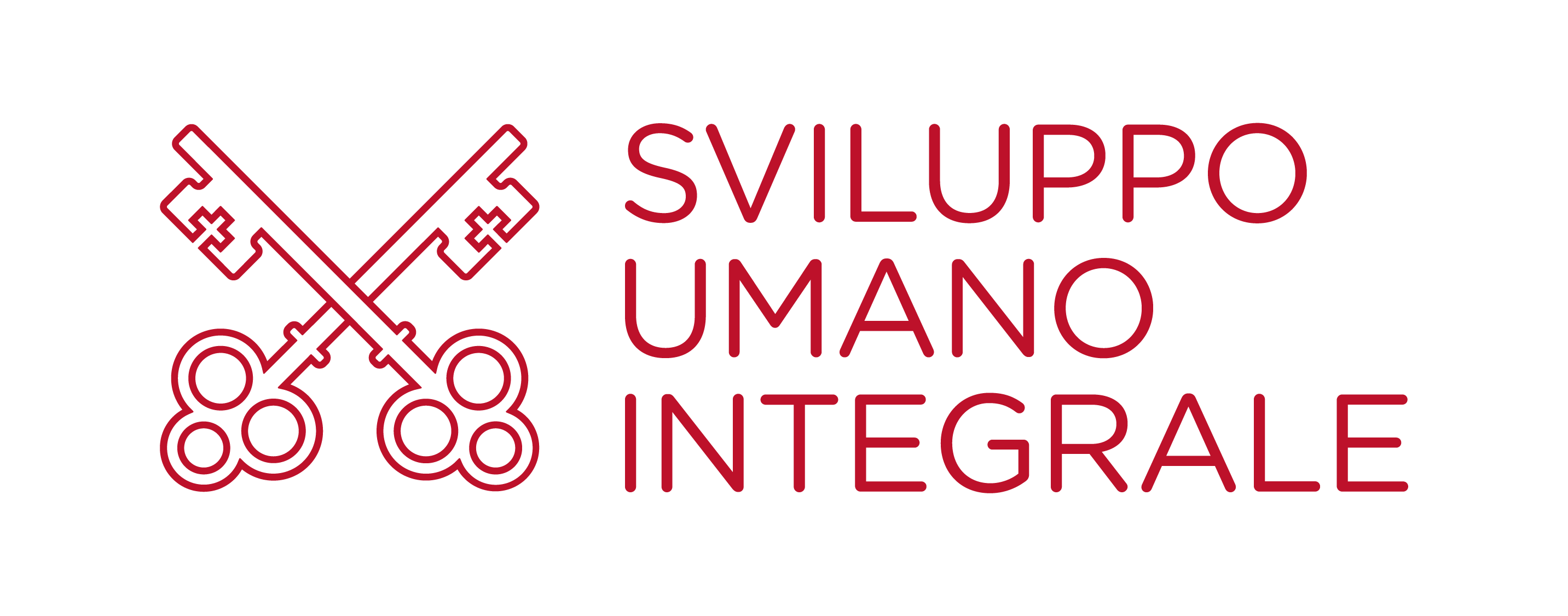03 Giu INTERVENTO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AL VERTICE DI GIUDICI E MAGISTRATI CONTRO IL TRAFFICO DELLE PERSONE UMANE E IL CRIMINE ORGANIZZATO [VATICANO, 3-4 GIUGNO 2016]
Posted at 00:00h
in
by mr_admin
Buona sera!
Vi saluto cordialmente e rinnovo l’espressione della mia stima per la vostra collaborazione nel contribuire al progresso umano e sociale, finalità della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.
Se mi rallegro di tale contributo e mi compiaccio con voi, è anche in considerazione del nobile servizio che potete offrire all’umanità, sia approfondendo la conoscenza di questo fenomeno così attuale, cioè l’indifferenza nel mondo globalizzato e le sue forme estreme, sia nelle soluzioni per affrontare tale sfida, adoperandovi per migliorare le condizioni di vita dei più bisognosi tra i nostri fratelli e sorelle. Seguendo Cristo, la Chiesa è chiamata a impegnarsi. Ossia, non vale l’adagio illuministico secondo il quale la Chiesa non deve mettersi in politica; la Chiesa deve mettersi nella “grande” politica perché – cito Paolo VI – “la politica è una delle forme più alte dell’amore, della carità”. E La Chiesa è anche chiamata ad essere fedele alle persone, ancor più se si considerano le situazioni in cui si toccano le piaghe e le sofferenze drammatiche, e nelle quali sono coinvolti i valori, l’etica, le scienze sociali e la fede; situazioni nelle quali la vostra testimonianza di persone e umanisti, unita alla vostra specifica competenza sociale, è particolarmente apprezzata.
Nel corso di questi ultimi anni non sono mancate importanti attività della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali sotto il forte impulso della sua Presidente, del Cancelliere e di alcuni collaboratori esterni di rinomato prestigio, che ringrazio di cuore. Attività in difesa della dignità e libertà degli uomini e delle donne di oggi e, in particolare, volte a sradicare la tratta e il traffico di persone e le nuove forme di schiavitù come il lavoro forzato, la prostituzione, il traffico di organi, il commercio della droga, la criminalità organizzata. Come ha detto il mio predecessore Benedetto XVI, e come ho affermato io stesso in diverse occasioni, questi sono veri e propri crimini di lesa umanità che devono essere riconosciuti tali da tutte le autorità religiose, politiche e sociali, e sanciti dalle leggi nazionali e internazionali.
L’incontro con i capi religiosi delle principali religioni che oggi influiscono sul mondo globale, il 2 dicembre 2014, come pure il vertice degli amministratori e dei sindaci delle città più importanti del mondo, il 21 luglio 2015, hanno manifestato la volontà di questa Istituzione di perseguire l’eliminazione delle nuove forme di schiavitù. Conservo un particolare ricordo di questi due incontri, come anche dei significativi seminari dei giovani, tutti promossi dall’Accademia. Qualcuno potrebbe pensare che l’Accademia debba muoversi piuttosto in un ambito di scienze pure, di considerazioni più teoriche. Questo risponde certamente ad una concezione illuministica di quello che deve essere un’Accademia. Ma un’Accademia deve avere radici e radici nel concreto, perché altrimenti corre il rischio di sviluppare una riflessione liquida, che si vaporizza e non porta a nulla. Questo divorzio tra l’idea e la realtà è chiaramente un fenomeno culturale passato, proprio piuttosto dell’Illuminismo, ma che ha ancora la sua incidenza.
Ora, ispirata dai medesimi obiettivi, l’Accademia ha convocato voi, giudici e pubblici ministeri provenienti da tutto il mondo, con esperienza e saggezza pratica nello sradicamento della tratta, del traffico di persone e della criminalità organizzata. Siete venuti in rappresentanza dei vostri colleghi con il lodevole intento di progredire nella piena consapevolezza di tali flagelli e, conseguentemente, di manifestare la vostra insostituibile missione di fronte alle nuove sfide poste dalla globalizzazione dell’indifferenza, rispondendo alla crescente richiesta della società e nel rispetto delle leggi nazionali e internazionali. Farsi carico della propria vocazione significa anche sentirsi e proclamarsi liberi. Giudici e pubblici ministeri liberi: da che cosa? Dalle pressioni dei governi; liberi dalle istituzioni private e, naturalmente, liberi dalle “strutture di peccato” di cui parlava il mio predecessore san Giovanni Paolo II, in particolare liberi da quella “struttura di peccato” che è la criminalità organizzata. Io so che voi siete sottoposti a pressioni, sottoposti a minacce in tutto questo; e so che oggi essere giudici, essere pubblici ministeri significa rischiare la pelle, e questo merita un riconoscimento al coraggio di quelli che vogliono continuare ad essere liberi nell’esercizio delle loro funzione giuridica. Senza questa libertà, il potere giudiziario di una nazione si corrompe e genera corruzione. Tutti conosciamo la caricatura della giustizia, in questi casi: la giustizia con gli occhi bendati: le cade la benda e le tappa la bocca.
Fortunatamente, per la realizzazione di questo complesso e delicato progetto umano e cristiano: liberare l’umanità dalle nuove schiavitù e dal crimine organizzato, progetto che l’Accademia persegue rispondendo alla mia richiesta, si può anche contare sull’importante e decisiva sinergia delle Nazioni Unite. C’è una maggiore coscienza di questo, una forte coscienza. Mi congratulo con i rappresentanti dei 193 Paesi membri dell’ONU, che hanno approvato all’unanimità i nuovi obiettivi dello sviluppo sostenibile e integrale, e in particolare la meta 8.7. Essa recita così: “Adottare misure immediate ed efficaci per sradicare il lavoro forzato, porre fine alle forme moderne di schiavitù e alla tratta di esseri umani, e assicurare il divieto e l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro infantile, inclusi il reclutamento e l’utilizzo di bambini soldato, e, al più tardi entro il 2025, porre fine al lavoro infantile in tutte le sue forme”. Fin qui la Risoluzione. Si può ben dire che adesso è un imperativo morale per tutti Paesi membri dell’ONU attuare tali obiettivi e tale meta.
Perciò è necessario generare un moto trasversale e ondulare, una “buona onda”, che abbracci tutta la società dall’alto in basso e viceversa, dalla periferia al centro e viceversa, dai capi fino alle comunità, e dai popoli e dall’opinione pubblica fino ai più alti livelli dirigenziali. La realizzazione di questo esige che, come hanno già fatto le autorità religiose e sociali e i sindaci, così anche i giudici prendano piena coscienza di tale sfida, sentano l’importanza della propria responsabilità davanti alla società, condividano le proprie esperienze e buone pratiche e agiscano insieme – è importante, in comunione, in comunità, che agiscano insieme – per aprire spazi e nuove vie di giustizia a vantaggio della promozione della dignità umana, della libertà, della responsabilità, della felicità e, in definitiva, della pace. Senza cedere al gusto della simmetria, potremmo dire che il giudice sta alla giustizia come il religioso e il filosofo alla morale, e come il governante o ogni altra figura che impersona il potere sovrano sta alla politica. Ma solamente nella figura del giudice si riconosce la giustizia come il primo attributo della società. E questo bisogna rivalutarlo, perché la tendenza sempre maggiore è quella di “liquefare” la figura del giudice attraverso le pressioni e quanto ho menzionato prima. E tuttavia è la prima caratteristica della società. Viene già dalla stessa tradizione bilica, non è così? Mosè ha bisogno di istituire 70 giudici perché lo aiutino, che giudichino i casi: il giudice, a cui si ricorre. E anche in questo processo di liquefazione, la realtà decisiva, la realtà concreta riguarda i popoli. Ossia, i popoli hanno un’entità che dà loro consistenza, che li fa crescere, avere i propri progetti, farsi carico dei propri fallimenti, dei propri ideali; però stanno anche soffrendo un processo di “liquefazione” e tutto ciò che è la consistenza concreta di un popolo tende a trasformarsi nella mera identità nominale di un cittadino, e un popolo non è la stessa cosa di un gruppo di cittadini. Il giudice è la prima caratteristica di una società di popolo.
L’Accademia, convocando i giudici, non aspira se non a collaborare secondo la misura delle sue possibilità in sintonia con il citato obiettivo dell’ONU. Vanno qui ringraziate quelle nazioni che, tramite gli Ambasciatori presso la Santa Sede, non sono rimaste indifferenti o arbitrariamente critiche, ma al contrario hanno attivamente collaborato con l’Accademia per la realizzazione di questo vertice. Gli Ambasciatori che non hanno sentito questa necessità, o che se ne sono lavati le mani, o hanno pensato che non era poi così necessario, li aspettiamo per la prossima riunione.
Chiedo ai giudici di realizzare la propria vocazione e la propria missione essenziale: stabilire la giustizia, senza la quale non vi è ordine, né sviluppo sostenibile e integrale, né tantomeno pace sociale. Senza dubbio, uno dei più grandi mali sociali del mondo odierno è la corruzione a tutti i livelli, la quale indebolisce qualunque governo, indebolisce la democrazia partecipativa e l’attività giudiziaria. A voi, giudici, spetta il dovere di fare giustizia, e vi chiedo una speciale attenzione per fare giustizia nell’ambito della tratta e del traffico di persone e, di fronte a ciò e al crimine organizzato, vi chiedo di guardarsi dal cadere nella ragnatela delle corruzioni.
Quando diciamo “fare giustizia”, come voi ben sapete, non intendiamo che si debba cercare il castigo per sé stesso, ma che, quando occorrono le pene, queste siano date per la rieducazione dei responsabili, in modo tale che si possa aprire loro una speranza di reinserimento nella società. Ossia, non c’è pena valida senza speranza. Una pena chiusa in sé stessa, che non dia spazio alla speranza, è una tortura, non è una pena. Su questo mi baso anche per affermare seriamente la posizione della Chiesa contro la pena di morte. Certo, mi diceva un teologo che nella concezione della teologia medievale e postmedievale, la pena di morte era legata a una speranza: “li affidiamo a Dio”. Ma i tempi sono cambiati e questo non è più possibile. Lasciamo che sia Dio a scegliere il momento… La speranza del reinserimento nella società: “Neppure l’omicida perde la sua dignità personale e Dio stesso se ne fa garante” (Giovanni Paolo II, Enc. Evangelium vitae, 9). E se questa delicata congiunzione tra giustizia e misericordia, che in fondo è preparare per un reinserimento, vale per i responsabili dei crimini di lesa umanità come anche per ogni essere umano, a fortiori vale per le vittime che, come indica il loro stesso nome, sono più passive che attive nell’esercizio della loro libertà, essendo cadute nella trappola dei nuovi cacciatori di schiavi. Vittime molte volte tradite fin nel più intimo e più sacro della loro persona, cioè nell’amore che esse aspirano a dare e a ricevere, e che la loro famiglia deve loro o che viene loro promesso da pretendenti o mariti, che invece finiscono per venderle sul mercato del lavoro forzato, della prostituzione o della vendita di organi.
I giudici sono chiamati oggi più che mai a porre grande attenzione alle necessità delle vittime. Sono le prime che devono essere riabilitate e reintegrate nella società, e per loro si deve perseguire una lotta senza quartiere ai trafficanti e ai carnefici. Non vale il vecchio adagio: “Sono cose che esistono da che mondo è mondo”. Le vittime possono cambiare e di fatto sappiamo che cambiano vita con l’aiuto di buoni giudici, delle persone che le assistono e di tutta la società. Sappiamo che non poche di queste persone sono avvocati, politici o politiche, scrittori brillanti o hanno qualche ufficio affermato per servire in modo efficace il bene comune. Sappiamo quanto è importante che ogni vittima trovi il coraggio di parlare del suo essere vittima come di un passato che ha superato coraggiosamente essendo ora un sopravvissuto, o, meglio, una persona con qualità di vita, con dignità recuperata e libertà assunta. E su questo tema del reinserimento, vorrei comunicare un’esperienza vissuta. A me piace, quando vado in una città, visitare il carcere. Ne ho visitati diversi… E’ interessante – senza voler offendere nessuno – è un’impressione generale: ho visto che le carceri in cui il direttore è una donna vanno meglio di quelle in cui il direttore è un uomo. Questo non è femminismo! E’ interessante. La donna ha, riguardo al reinserimento, un “fiuto” speciale, una sensibilità speciale che, senza mancare di energia, ricolloca queste persone, le riposiziona. Alcuni attribuiscono questo fatto alla radice della maternità… Ma è interessante, lo lascio come esperienza personale; vale la pensa ripensarlo. E qui in Italia c’è un’alta percentuale di carceri dirette da donne, molte donne giovani, rispettate e che hanno un buon modo di trattare con i detenuti. Un’altra esperienza che ho è che nelle udienze del mercoledì non è raro che venga un gruppo di detenuti – di questo o quel carcere –, accompagnati dal direttore o dalla direttrice, sono lì… Sono tutti gesti di reinserimento.
Voi siete chiamati a dare speranza nel fare la giustizia. Dalla vedova che chiede giustizia insistentemente, di cui parla il Vangelo (Lc 18,1-8), fino alle vittime di oggi, tutte alimentano un’aspirazione alla giustizia, come speranza che l’ingiustizia che attraversa questo mondo non sia l’ultima realtà, non abbia l’ultima parola.
A volte può essere di giovamento applicare, secondo modalità proprie di ogni paese, di ogni continente e di ogni tradizione giuridica, la prassi italiana di recuperare i beni male acquistati dai trafficanti e dai criminali per offrire alla società e, in concreto, per il reinserimento delle vittime. La riabilitazione delle vittime e il loro reinserimento nella società, sempre realmente possibile, è il bene maggiore che possiamo fare a loro stesse, alla comunità e alla pace sociale. Certo, il lavoro è duro; non finisce con la sentenza, finisce dopo, facendo in modo che ci sia un accompagnamento, una crescita, un reinserimento, una riabilitazione della vittima e del carnefice.
Se c’è una cosa che attraversa le beatitudini evangeliche e il protocollo del giudizio divino con cui tutti saremo giudicati di Matteo 25, è il tema della giustizia: “Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, beati quelli che soffrono per la giustizia, beati quelli che piangono, beati i miti, beati gli operatori di pace”; “Benedetti dal Padre mio quelli che trattano il più bisognoso e il più piccolo dei miei fratelli come me stesso”. Essi o esse – e qui è il caso di riferirci in particolare ai giudici – avranno la ricompensa più grande: possederanno la terra, saranno chiamati e saranno figli di Dio, vedranno Dio, e gioiranno eternamente con il Padre celeste.
In questo spirito, mi permetto di chiedere a giudici, pubblici ministeri e membri dell’Accademia di continuare la loro opera e realizzare, secondo le proprie possibilità e con l’aiuto della grazia, le valide e benemerite iniziative al servizio delle persone e del bene comune. Tante grazie!