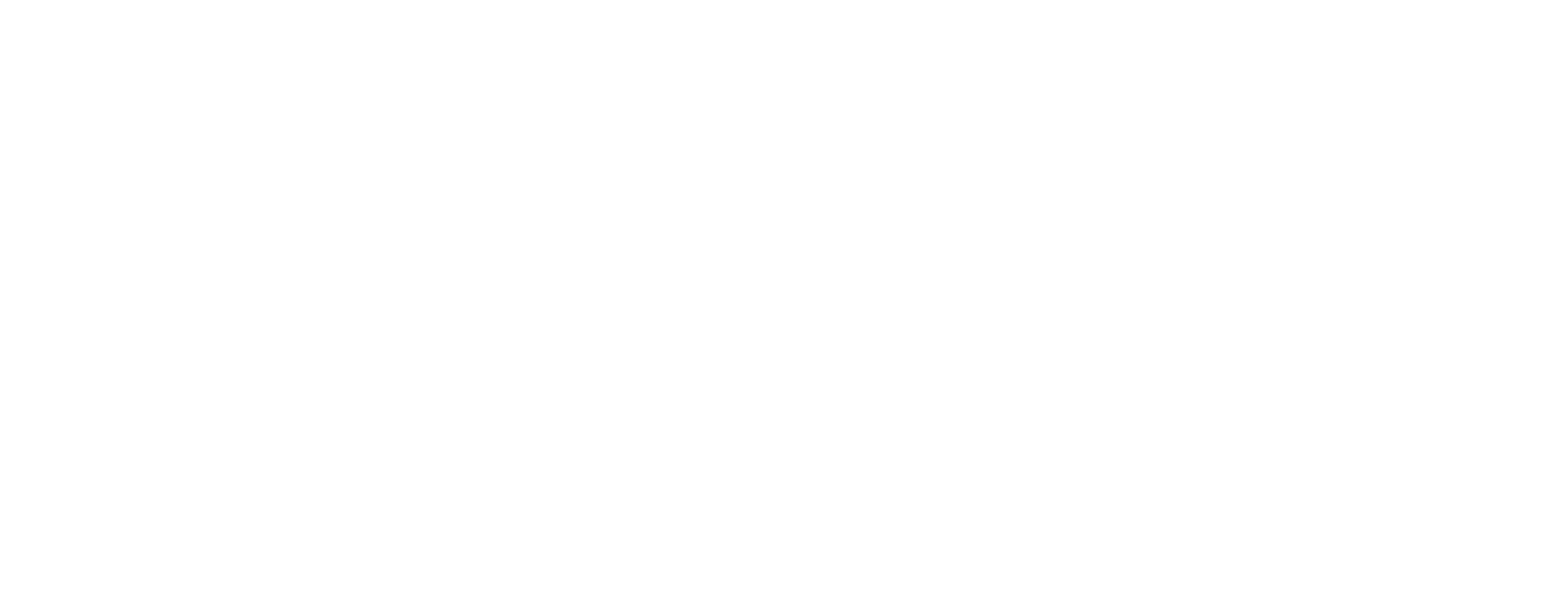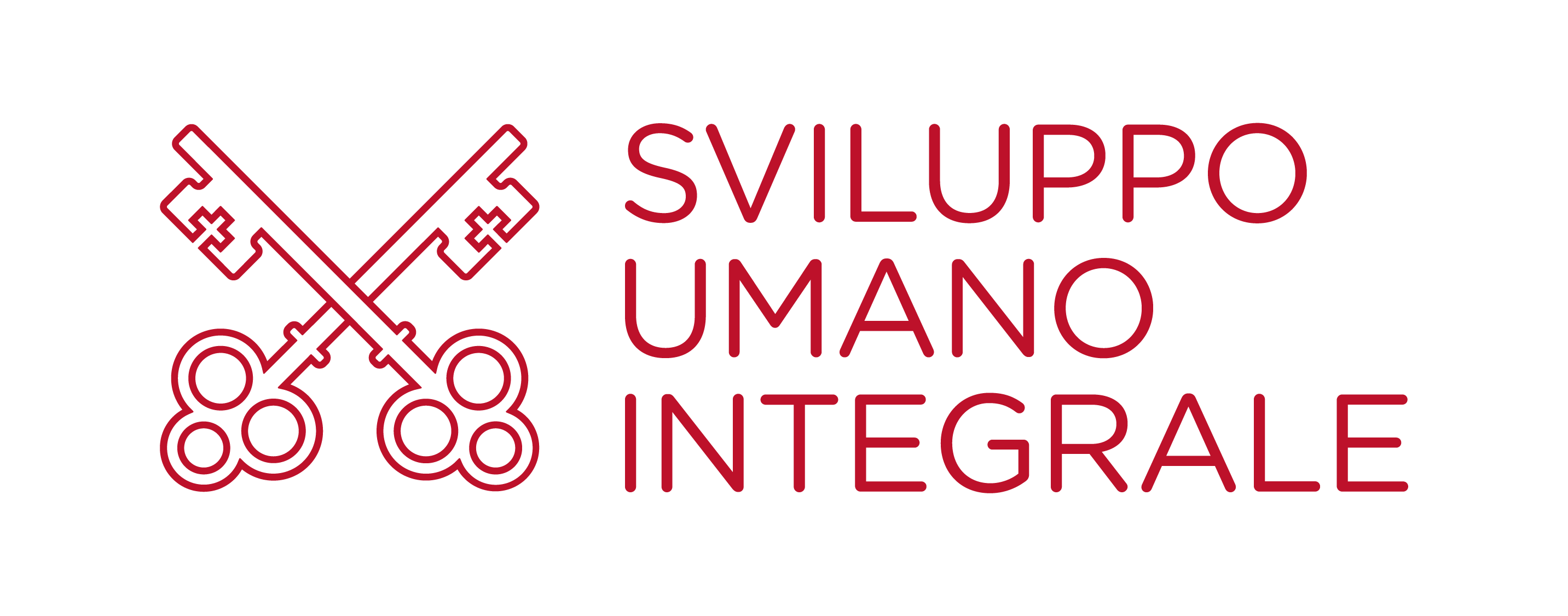23 Feb VISITA DEL SANTO PADRE FRANCESCO A BARI IN OCCASIONE DELL’INCONTRO DI RIFLESSIONE E SPIRITUALITÀ “MEDITERRANEO FRONTIERA DI PACE” INCONTRO CON I VESCOVI DEL MEDITERRANEO DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Posted at 00:00h
in
by mr_admin
Cari fratelli, sono lieto di incontrarvi e grato ad ognuno di voi per avere accettato l’invito della Conferenza Episcopale Italiana a partecipare a questo incontro che riunisce le Chiese del Mediterraneo. E guardando oggi questa chiesa [la Basilica di San Nicola], mi viene in mente l’altro incontro, quello che abbiamo avuto con i capi delle Chiese cristiane – ortodosse, cattoliche… – qui a Bari. È la seconda volta in pochi mesi che si fa un gesto di unità così: quella era la prima volta, dopo il grande scisma, che eravamo tutti insieme; e questa è una prima volta di tutti i vescovi che si affacciano sul Mediterraneo. Credo che potremmo chiamare Bari la capitale dell’unità, dell’unità della Chiesa – se Monsignor Cacucci lo permette! Grazie dell’accoglienza, Eccellenza, grazie. Quando, a suo tempo, il Cardinale Bassetti mi presentò l’iniziativa, la accolsi subito con gioia, intravedendo in essa la possibilità di avviare un processo di ascolto e di confronto, con cui contribuire all’edificazione della pace in questa zona cruciale del mondo. Per tale ragione ho voluto essere presente e testimoniare il valore contenuto nel nuovo paradigma di fraternità e collegialità, di cui voi siete espressione. Mi è piaciuta quella parola che voi avete aggiunto al dialogo: convivialità. Trovo significativa la scelta di tenere questo incontro nella città di Bari, così importante per i legami che intrattiene con il Medio Oriente come con il continente africano, segno eloquente di quanto radicate siano le relazioni tra popoli e tradizioni diverse. La diocesi di Bari, poi, da sempre tiene vivo il dialogo ecumenico e interreligioso, adoperandosi instancabilmente a stabilire legami di reciproca stima e di fratellanza. Non è un caso se proprio qui, un anno e mezzo fa – come ho detto – ho scelto di incontrare i responsabili delle comunità cristiane del Medio Oriente, per un importante momento di confronto e comunione, che aiutasse Chiese sorelle a camminare insieme e sentirsi più vicine. In questo particolare contesto, vi siete riuniti per riflettere sulla vocazione e le sorti del Mediterraneo, sulla trasmissione della fede e la promozione della pace. Il Mare nostrum è il luogo fisico e spirituale nel quale ha preso forma la nostra civiltà, come risultato dell’incontro di popoli diversi. Proprio in virtù della sua conformazione, questo mare obbliga i popoli e le culture che vi si affacciano a una costante prossimità, invitandoli a fare memoria di ciò che li accomuna e a rammentare che solo vivendo nella concordia possono godere delle opportunità che questa regione offre dal punto di vista delle risorse, della bellezza del territorio, delle varie tradizioni umane. Ai nostri giorni, l’importanza di tale area non è diminuita in seguito alle dinamiche determinate dalla globalizzazione; al contrario, quest’ultima ha accentuato il ruolo del Mediterraneo, quale crocevia di interessi e vicende significative dal punto di vista sociale, politico, religioso ed economico. Il Mediterraneo rimane una zona strategica, il cui equilibrio riflette i suoi effetti anche sulle altre parti del mondo. Si può dire che le sue dimensioni siano inversamente proporzionali alla sua grandezza, la quale porta a paragonarlo, più che a un oceano, a un lago, come già fece Giorgio La Pira. Definendolo “il grande lago di Tiberiade”, egli suggerì un’analogia tra il tempo di Gesù e il nostro, tra l’ambiente in cui Lui si muoveva e quello in cui vivono i popoli che oggi lo abitano. E come Gesù operò in un contesto eterogeneo di culture e credenze, così noi ci collochiamo in un quadro poliedrico e multiforme, lacerato da divisioni e diseguaglianze, che ne aumentano l’instabilità. In questo epicentro di profonde linee di rottura e di conflitti economici, religiosi, confessionali e politici, siamo chiamati a offrire la nostra testimonianza di unità e di pace. Lo facciamo a partire dalla nostra fede e dall’appartenenza alla Chiesa, chiedendoci quale sia il contributo che, come discepoli del Signore, possiamo offrire a tutti gli uomini e le donne dell’area mediterranea. La trasmissione della fede non può che trarre frutto dal patrimonio di cui il Mediterraneo è depositario. È un patrimonio custodito dalle comunità cristiane, reso vivo mediante la catechesi e la celebrazione dei sacramenti, la formazione delle coscienze e l’ascolto personale e comunitario della Parola del Signore. In particolare, nella pietà popolare l’esperienza cristiana trova un’espressione tanto significativa quanto irrinunciabile: davvero la devozione del popolo è, per lo più, espressione di fede semplice e genuina. E su questo mi piace citare spesso quel gioiello che è il numero 48 dell’ Evangelii nuntiandi sulla pietà popolare, dove San Paolo VI cambia il nome di “religiosità” in “pietà”, e dove sono presentate le sue ricchezze e anche le sue mancanze. Quel numero deve essere di guida nel nostro annuncio del Vangelo ai popoli. In quest’area, un deposito di enorme potenzialità è anche quello artistico, che unisce i contenuti della fede alla ricchezza delle culture, alla bellezza delle opere d’arte. È un patrimonio che attrae continuamente milioni di visitatori da tutto il mondo e che va custodito con cura, quale preziosa eredità ricevuta “in prestito” e da consegnare alle generazioni future. Su questo sfondo l’annuncio del Vangelo non può disgiungersi dall’impegno per il bene comune e ci spinge ad agire come instancabili operatori di pace. Oggi l’area del Mediterraneo è insidiata da tanti focolai di instabilità e di guerra, sia nel Medio Oriente, sia in vari Stati del nord Africa, come pure tra diverse etnie o gruppi religiosi e confessionali; né possiamo dimenticare il conflitto ancora irrisolto tra israeliani e palestinesi, con il pericolo di soluzioni non eque e, quindi, foriere di nuove crisi. La guerra, che orienta le risorse all’acquisto di armi e allo sforzo militare, distogliendole dalle funzioni vitali di una società, quali il sostegno alle famiglie, alla sanità e all’istruzione, è contraria alla ragione, secondo l’insegnamento di san Giovanni XXIII (cfr Enc. Pacem in terris, 62; 67). In altre parole, essa è una follia, perché è folle distruggere case, ponti, fabbriche, ospedali, uccidere persone e annientare risorse anziché costruire relazioni umane ed economiche. È una pazzia alla quale non ci possiamo rassegnare: mai la guerra potrà essere scambiata per normalità o accettata come via ineluttabile per regolare divergenze e interessi contrapposti. Mai. Il fine ultimo di ogni società umana rimane la pace, tanto che si può ribadire che «non c’è alternativa alla pace, per nessuno». Non c’è alcuna alternativa sensata alla pace, perché ogni progetto di sfruttamento e supremazia abbruttisce chi colpisce e chi ne è colpito, e rivela una concezione miope della realtà, dato che priva del futuro non solo l’altro, ma anche se stessi. La guerra appare così come il fallimento di ogni progetto umano e divino: basta visitare un paesaggio o una città, teatri di un conflitto, per accorgersi come, a causa dell’odio, il giardino si trasformi in una terra desolata e inospitale e il paradiso terrestre in un inferno. E a questo io vorrei aggiungere il grave peccato di ipocrisia, quando nei convegni internazionali, nelle riunioni, tanti Paesi parlano di pace e poi vendono le armi ai Paesi che sono in guerra. Questo si chiama la grande ipocrisia. La costruzione della pace, che la Chiesa e ogni istituzione civile devono sempre sentire come priorità, ha come presupposto indispensabile la giustizia. Essa è calpestata dove sono ignorate le esigenze delle persone e dove gli interessi economici di parte prevalgono sui diritti dei singoli e della comunità. La giustizia è ostacolata, inoltre, dalla cultura dello scarto, che tratta le persone come fossero cose, e che genera e accresce le diseguaglianze, così che in modo stridente sulle sponde dello stesso mare vivono società dell’abbondanza e altre in cui molti lottano per la sopravvivenza. A contrastare tale cultura contribuiscono in maniera decisiva le innumerevoli opere di carità, di educazione e di formazione attuate dalle comunità cristiane. E ogni volta che le diocesi, le parrocchie, le associazioni, il volontariato – il volontariato è uno dei grandi tesori della pastorale italiana – o i singoli si adoperano per sostenere chi è abbandonato o nel bisogno, il Vangelo acquista nuova forza di attrazione. Nel perseguire il bene comune – che è un altro nome della pace – è da assumere il criterio indicato dallo stesso La Pira: lasciarsi guidare dalle «attese della povera gente». Tale principio, che non è mai accantonabile in base a calcoli o a ragioni di convenienza, se assunto in modo serio, permette una svolta antropologica radicale, che rende tutti più umani. A cosa serve, del resto, una società che raggiunge sempre nuovi risultati tecnologici, ma che diventa meno solidale verso chi è nel bisogno? Con l’annuncio evangelico, noi trasmettiamo invece la logica per la quale non ci sono ultimi e ci sforziamo affinché la Chiesa, le Chiese, mediante un impegno sempre più attivo, sia segno dell’attenzione privilegiata per i piccoli e i poveri, perché «quelle membra del corpo che sembrano più deboli, sono più necessarie» (1 Cor 12,22) e, «se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme» (1 Cor 12,26). Tra coloro che nell’area del Mediterraneo più faticano, vi sono quanti fuggono dalla guerra o lasciano la loro terra in cerca di una vita degna dell’uomo. Il numero di questi fratelli – costretti ad abbandonare affetti e patria e ad esporsi a condizioni di estrema precarietà – è andato aumentando a causa dell’incremento dei conflitti e delle drammatiche condizioni climatiche e ambientali di zone sempre più ampie. È facile prevedere che tale fenomeno, con le sue dinamiche epocali, segnerà la regione mediterranea, per cui gli Stati e le stesse comunità religiose non possono farsi trovare impreparati. Sono interessati i Paesi attraversati dai flussi migratori e quelli di destinazione finale, ma lo sono anche i Governi e le Chiese degli Stati di provenienza dei migranti, che con la partenza di tanti giovani vedono depauperarsi il loro futuro. Siamo consapevoli che in diversi contesti sociali è diffuso un senso di indifferenza e perfino di rifiuto, che fa pensare all’atteggiamento, stigmatizzato in molte parabole evangeliche, di quanti si chiudono nella propria ricchezza e autonomia, senza accorgersi di chi, con le parole o semplicemente con il suo stato di indigenza, sta invocando aiuto. Si fa strada un senso di paura, che porta ad alzare le proprie difese davanti a quella che viene strumentalmente dipinta come un’invasione. La retorica dello scontro di civiltà serve solo a giustificare la violenza e ad alimentare l’odio. L’inadempienza o, comunque, la debolezza della politica e il settarismo sono cause di radicalismi e terrorismo. La comunità internazionale si è fermata agli interventi militari, mentre dovrebbe costruire istituzioni che garantiscano uguali opportunità e luoghi nei quali i cittadini abbiano la possibilità di farsi carico del bene comune. A nostra volta, fratelli, alziamo la voce per chiedere ai Governi la tutela delle minoranze e della libertà religiosa. La persecuzione di cui sono vittime soprattutto – ma non solo – le comunità cristiane è una ferita che lacera il nostro cuore e non ci può lasciare indifferenti. Nel contempo, non accettiamo mai che chi cerca speranza per mare muoia senza ricevere soccorso o che chi giunge da lontano diventi vittima di sfruttamento sessuale, sia sottopagato o assoldato dalle mafie. Certo, l’accoglienza e una dignitosa integrazione sono tappe di un processo non facile; tuttavia, è impensabile poterlo affrontare innalzando muri. A me fa paura quando ascolto qualche discorso di alcuni leader delle nuove forme di populismo, e mi fa sentire discorsi che seminavano paura e poi odio nel decennio ’30 del secolo scorso. Questo processo di accoglienza e dignitosa integrazione è impensabile, ho detto, poterlo affrontare innalzando muri. In tale modo, piuttosto, ci si preclude l’accesso alla ricchezza di cui l’altro è portatore e che costituisce sempre un’occasione di crescita. Quando si rinnega il desiderio di comunione, inscritto nel cuore dell’uomo e nella storia dei popoli, si contrasta il processo di unificazione della famiglia umana, che già si fa strada tra mille avversità. La settimana scorsa, un artista torinese mi ha inviato un quadretto, fatto con la tecnica del bruciato sopra il legno, sulla fuga in Egitto e c’era un San Giuseppe, non così tranquillo come siamo abituati a vederlo nelle immaginette, ma un San Giuseppe con l’atteggiamento di un rifugiato siriano, col bambino sulle spalle: fa vedere il dolore, senza addolcire il dramma di Gesù Bambino quando dovette fuggire in Egitto. È lo stesso che sta succedendo oggi. Il Mediterraneo ha una vocazione peculiare in tal senso: è il mare del meticciato, «culturalmente sempre aperto all’incontro, al dialogo e alla reciproca inculturazione». Le purezze delle razze non hanno futuro. Il messaggio del meticciato ci dice tanto. Essere affacciati sul Mediterraneo rappresenta dunque una straordinaria potenzialità: non lasciamo che a causa di uno spirito nazionalistico, si diffonda la persuasione contraria, che cioè siano privilegiati gli Stati meno raggiungibili e geograficamente più isolati. Solamente il dialogo permette di incontrarsi, di superare pregiudizi e stereotipi, di raccontare e conoscere meglio sé stessi. Il dialogo e quella parola che ho sentito oggi: convivialità. Una particolare opportunità, a questo riguardo, è rappresentata dalle nuove generazioni, quando è loro assicurato l’accesso alle risorse e sono poste nelle condizioni di diventare protagoniste del loro cammino: allora si rivelano linfa capace di generare futuro e speranza. Tale risultato è possibile solo dove vi sia un’accoglienza non superficiale, ma sincera e benevola, praticata da tutti e a tutti i livelli, sul piano quotidiano delle relazioni interpersonali come su quello politico e istituzionale, e promossa da chi fa cultura e ha una responsabilità più forte nei confronti dell’opinione pubblica. Per chi crede nel Vangelo, il dialogo non ha semplicemente un valore antropologico, ma anche teologico. Ascoltare il fratello non è solo un atto di carità, ma anche un modo per mettersi in ascolto dello Spirito di Dio, che certamente opera anche nell’altro e parla al di là dei confini in cui spesso siamo tentati di imbrigliare la verità. Conosciamo poi il valore dell’ospitalità: «Alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo» (Eb 13,2). C’è bisogno di elaborare una teologia dell’accoglienza e del dialogo, che reinterpreti e riproponga l’insegnamento biblico. Può essere elaborata solo se ci si sforza in ogni modo di fare il primo passo e non si escludono i semi di verità di cui anche gli altri sono depositari. In questo modo, il confronto tra i contenuti delle diverse fedi potrà riguardare non solo le verità credute, ma temi specifici, che diventano punti qualificanti di tutta la dottrina. Troppo spesso la storia ha conosciuto contrapposizioni e lotte, fondate sulla distorta persuasione che, contrastando chi non condivide il nostro credo, stiamo difendendo Dio. In realtà, estremismi e fondamentalismi negano la dignità dell’uomo e la sua libertà religiosa, causando un declino morale e incentivando una concezione antagonistica dei rapporti umani. È anche per questo che si rende urgente un incontro più vivo tra le diverse fedi religiose, mosso da un sincero rispetto e da un intento di pace. Tale incontro muove dalla consapevolezza, fissata nel Documento sulla fratellanza firmato ad Abu Dhabi, che «i veri insegnamenti delle religioni invitano a restare ancorati ai valori della pace; a sostenere i valori della reciproca conoscenza, della fratellanza umana e della convivenza comune». Anche attorno al sostegno dei poveri e all’accoglienza dei migranti, si può quindi realizzare una più attiva collaborazione tra i gruppi religiosi e le diverse comunità, in modo che il confronto sia animato da intenti comuni e si accompagni a un impegno fattivo. Quanti insieme si sporcano le mani per costruire la pace e praticare l’accoglienza, non potranno più combattersi per motivi di fede, ma percorreranno le vie del confronto rispettoso, della solidarietà reciproca, della ricerca dell’unità. E il contrario è quello che ho sentito quando sono andato a Lampedusa, quell’aria di indifferenza: nell’isola c’era accoglienza, ma poi nel mondo la cultura dell’indifferenza. Questi sono gli auspici che desidero comunicarvi, cari Confratelli, a conclusione del fruttuoso e consolante incontro di questi giorni. Vi affido all’intercessione dell’apostolo Paolo, che per primo ha solcato il Mediterraneo, affrontando pericoli e avversità di ogni genere per portare a tutti il Vangelo di Cristo: il suo esempio vi indichi le vie lungo le quali proseguire il gioioso e liberante impegno di trasmettere la fede nel nostro tempo. Come mandato, vi consegno le parole del profeta Isaia, perché diano speranza e comunichino forza a voi e alle vostre rispettive comunità. Davanti alla desolazione di Gerusalemme a seguito dell’esilio, il profeta non cessa di intravedere un futuro di pace e prosperità: «Ricostruiranno le vecchie rovine, rialzeranno gli antichi ruderi, restaureranno le città desolate, devastate da più generazioni» (Is 61,4). Ecco l’opera che il Signore vi affida per questa amata area del Mediterraneo: ricostruire i legami che sono stati interrotti, rialzare le città distrutte dalla violenza, far fiorire un giardino laddove oggi ci sono terreni riarsi, infondere speranza a chi l’ha perduta ed esortare chi è chiuso in sé stesso a non temere il fratello. E guardare questo, che è già diventato cimitero, come un luogo di futura risurrezione di tutta l’area. Il Signore accompagni i vostri passi e benedica la vostra opera di riconciliazione e di pace. Grazie.